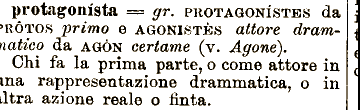È successo domenica scorsa.
Neil Armstrong, il primo uomo a calcare il suolo lunare è morto. Non era
vecchissimo, 82 anni. Gli è stato fatale il quarto by-pass coronarico. Eppure
il suo cuore aveva retto all’emozione più grande mai provata da essere umano.
Lui, per primo, ha mosso un passo al di fuori del nostro pianeta. Chi c’era,
quel 20 luglio 1969, fosse pure stato un pargolo, ricorda quell’eterna nottata
in diretta, in attesa dell’allunaggio. Domenica, nel dare la notizia della
scomparsa dell’astronauta simbolo di tante speranze, un po’ tutti i media si
sono dilungati sulle aspettative enormi che quell’evento scatenò nel mondo. Era
l’entrata ufficiale nel futuro, era la fantascienza che si faceva realtà. Ci
aspettavamo moltissimo. Immaginavamo un domani di navette che facevano la spola
tra la Terra e la Luna , basi lunari con
affascinanti astronaute, viaggi interstellari a velocità di curvatura. Ci
aspettavamo che quell’impronta sulla sabbia grigiastra della Luna ci rendesse,
per magia, tutti migliori. Perché l’assioma era: se siamo arrivati lassù,
allora possiamo sconfiggere le malattie, possiamo eliminare la fame nel mondo,
possiamo conquistare uguaglianza, libertà, giustizia sociale. Possiamo. Era
questa la parola chiave. Una parola che quarantatre anni hanno lentamente eroso
e depotenziato. Ha voluto usarla Obama per la sua campagna elettorale del 2008:
yes, we can. Sì, possiamo. Ma neanche lui, in realtà, ha potuto granché. Così,
mentre si diffondeva la notizia della morte di Neil Armstrong lo sguardo
tornava a terra. Un effetto che GoogleEarth renderebbe bene: lo spazio, il
pianeta Terra e poi una vertiginosa zoomata fino alla superficie. Per scoprire
che nella Siria dello scontro tra l’esercito di Bashar al Assad e le forze
ribelli i morti si contano a migliaia, compresi vecchi, donne e bambini. Che
negli Stati Uniti c’è un uomo politico per il quale neanche un legittimo
(legittimo?) stupro può giustificare un aborto. Che nel Cairo del dopo Mubarak
bande di ragazzini aggrediscono, insultano e picchiano le donne in strada. Che
nella civilissima Italia una donna che denuncia uno stupro avvenuto in un parco
cittadino della capitale viene guardata con sospetto. Perché, e citiamo
testualmente le parole del cronista: “Sono quelle sere in cui la vita non ti fa
sconti, ma lei l’ha realizzato troppo tardi. Altrimenti non avrebbe ingaggiato
una stupida lite… con l’uomo che… l’aveva strappata a un’esistenza fin troppo
randagia. Altrimenti non si sarebbe precipitata per le scale… per andare a
rimuginare su una panchina di un parco spelacchiato, all’una di notte, dove il
suo carnefice l’aspettava.” Quarantatre anni fa eravamo tutti lì a guardare il
cielo col fiato sospeso, convinti che quel piccolo passo nella sabbia lunare
fosse, come ci disse Armstrong con efficace retorica, “un grande balzo per
l’umanità”. Quarantatre anni dopo è la
Luna a guardarci e a vederci come ci ha sempre visti:
piccoli, litigiosi, incorreggibili.
Laura
Costantini