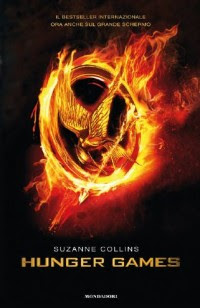Ciò che colpisce nella tragedia sono le storie minime. Spesso
la tragedia è troppo grande, troppo distante, troppo imprevedibile o
indecifrabile per toccarci veramente. Siamo assuefatti alla morte, purché
distante, estranea, reiterata. Le stragi del sabato sera, le morti sui posti di
lavoro, l’infinito rosario di attentati in medio Oriente, sciagure aeree o
marittime. Sono titoli su un giornale, sono lanci di un notiziario. Sono,
sempre più spesso, immagini tremolanti girate con un cellulare da un reporter
improvvisato. E tutto resta in superficie fino a quando non si scoperchiano i
particolari, le coincidenze, le fatalità. Quello appena trascorso è stato un
weekend di sangue per il nostro paese. In un sabato da corsa in spiaggia per la
prima tintarella, ci siamo svegliati con la notizia di un attentato. Un
attentato a una scuola. Una scuola intitolata a Francesca Morvillo Falcone. Una
scuola premiata per l’impegno civile contro la criminalità organizzata. Ma pur
sempre una scuola. Un istituto tecnico frequentato per lo più da ragazze. Ci
dicono che Brindisi è zona di mafia, la Sacra
Corona
Laura Costantini